Impresa familiare
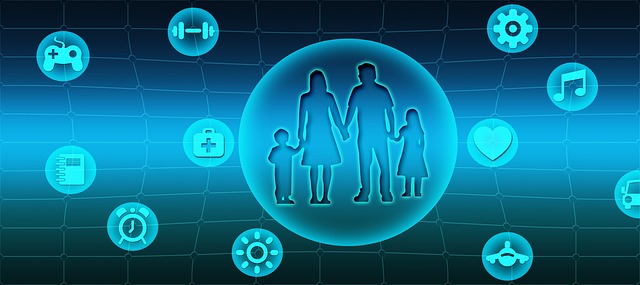
Il codice civile fornisce una particolare tutela al soggetto (entro un certo grado di parentela o affinità) che offre in modo costante il proprio lavoro nell’ambito della famiglia o dell’impresa gestita da un congiunto (art. 230 bis e ter c.c.).
Quando si ha impresa familiare?
Vediamo quali sono anzitutto i requisiti per tale tutela:
- questa disciplina non si applica se è configurabile un diverso rapporto giuridico (ad es.: rapporto di lavoro subordinato o autonomo). Si tratta quindi di una tutela “minima” invocabile sono quanto non siano applicabili altri istituti (Cass. S.U. 6/11/2014 n. 23676).
- Deve essere presente un’impresa, che può esser costituita sia con un contratto sia in forma tacita (es.: la famiglia esercita con continuità un’attività economica).
- I partecipanti: fanno parte dell’impresa il titolare ed i familiari, anche se non conviventi, che prestano il proprio lavoro con continuità e prevalenza. In particolare il coniuge (ed adesso anche la “parte” dell’unione civile – v. art. 1, comma 13, L. 76/2016), i parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado. Chi non riveste tale qualifica (c.d. terzo) può collaborare come lavoratore dipendente o autonomo. Anche un soggetto che non ha capacità piena di agire (es.: minorenne) può far parte dell’impresa familiare, ma nelle decisioni sarà rappresentato da chi esercita la potestà di genitore.
- l’attività continuativa e prevalente del familiare all’interno dell’impresa, da intendersi nel senso di attività non occasionale (anche se part-time). È necessario anche l’accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi, v. in questo senso Cass. civ., sez. lav., 18-04-2002, n. 5603). Ad esempio: il semplice lavoro casalingo non fornisce un accrescimento produttivo (Cass., sez. un., 89/1995).
Click here to learn more
I diritti dei partecipanti
Il lavoro fornito all’interno dell’impresa familiare si presume gratuito. Tuttavia al partecipante vengono riconosciuti particolari diritti ed in particolare:
Mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia. Questo diritto deve esser soddisfatto anche in caso di perdite e mancanza di utili (al contrario di quello che segue ). Non richiede la coabitazione.
Partecipazione agli utili, ai beni acquistati ed agli incrementi dell’impresa anche in ordine all’avviamento.
È importante sottolineare che il diritto agli utili non è scontato. Spetta, infatti, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato e, per quantificarlo, non può essere utilizzata la retribuzione percepita da un lavoratore dipendente che svolga attività analoga.
Inoltre il partecipante non avrà diritto ad utili se l’azienda non ne ha prodotti.
Ancora: se le parti non si sono accordate sulla distribuzione si presume che gli utili vadano reimpiegati in azienda . Per questo essi “maturano” (salvo patto contrario) solo alla cessazione dell’impresa o della singola partecipazione (Cass. 5224/2016).
Click here to learn more
La partecipazione agli utili può essere liquidata in danaro (anche in più annualità) alla cessazione della collaborazione ovvero in caso di vendita dell’azienda.
Il diritto agli utili è intrasferibile, salvo il caso di cessione ad altri familiari che possono diventare partecipanti per legge e sempre che vi sia il consenso di tutti gli altri.
Il diritto si prescrive in dieci anni.
In caso di divisione ereditaria o trasferimento d’azienda i familiari partecipanti possono vantare un diritto di prelazione.
Il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l’onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota della propria partecipazione. In giudizio può ricorrere anche alle c.d. presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali. Sul familiare titolare dell’impresa grava invece l’onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici oltre di dimostrare il pagamento degli utili spettanti a ciascun partecipante in ragione della quota (Cass., 27966/2018).
Partecipazione alle decisioni attinenti l’impresa. Il titolare ha il potere di gestione ordinaria. I familiari partecipanti adottano, a maggioranza, le decisione inerenti gli utili e gli incrementi, gestione straordinaria, indirizzi produttivi e cessazione dell’attività.
Il lavoro della donna è, ovviamente, equivalente a quello dell’uomo.
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i familiari che prestano,in via non occasionale, la propria opera nell’ambito dell’impresa familiare (v. art. 4, n. 6, DPR 1124/1965). Il lavoro nell’impresa familiare è invece privo di tutela previdenziale se non qualificabile come lavoro subordinato o co.co.co. (v. Circ. INPS. 179/1989).
I diritti del “convivente”
In materia di “convivenza” si deve distinguere se trattasi di:
a) Convivente di fatto (v. art. 1, comma 46, L. 76/2016). La legge 76/2016 (in vigore dal 5 giugno 2016) ha inserito nel codice civile l’art. 230 ter. Esso stabilisce che il convivente di fatto (secondo la definizione di legge) il quale presta il proprio lavoro stabilmente all’interno dell’impresa dell’altro convivente, ha diritto ad una partecipazione agli utili, ai beni con essi acquistati, agli incrementi anche per l’avviamento, proporzionale al lavoro prestato.
Tale diritto non spetta se fra i conviventi sussiste altra tipologia di rapporto (società o lavoro subordinato).
b) Convivente more uxorio (soggetto legato da rapporto affettivo ad altra persona in comunione di vita senza vincolo del matrimonio). Trattasi di rapporto non disciplinato dalla legge. In tempi recenti la giurisprudenza ritiene rilevante tale rapporto anche in tema di impresa familiare (Cass. 5632/2006).
Click here to learn more
